Indipendentemente dal fatto che il vino sia buono o meno, chiedere all’oste se il vino è buono non è un criterio saggio per farsi un’idea sul vino. L’oste, che sia egli una persona onesta e che venda il migliore dei vini, non è credibile quando parla del vino che vende per via di un conflitto di interessi: gli conviene che il vino sia venduto e quindi gli conviene un giudizio positivo sul vino.
La credibilità di un giudizio, quindi, si basa sull’indipendenza di chi lo emette rispetto al prodotto giudicato.
Ma che importa? L’oste in fondo è solo quello che lo vende; per sapere, prima di comprarlo, se il vino è buono ci rivolgeremo a chi il vino assaggia e recensisce di professione.
Un persona che, di professione, assaggia e recensisce vini è quasi certamente un’esperta di vini e fra le più qualificate cui chiedere un giudizio. Tuttavia, dobbiamo domandarci quale sia il rapporto fra questa persona e le aziende che producono quei vini.
Affinché un giudizio su di un prodotto sia credibile abbiamo bisogno di sapere che per la persona che lo emette non ci siano valutazioni più convenienti di altre, ovverosia che non le interessi economicamente la sorte commerciale di quel prodotto o che non abbia legami economici con chi quel prodotto produce e vuole vendere (viceversa, alcune valutazioni le darebbero un vantaggio economico e altre uno svantaggio e il suo giudizio sarebbe così non credibile per conflitto di interessi).
Nota bene: l’eventuale indipendenza del giudizio non garantisce nulla sul suo valore soprattutto perché, quando si parla di gusti, non abbiamo la possibilità di verificare in modo inappellabile se essi siano giusti o sbagliati. Per questo, sono importanti le premesse oggettive al giudizio soggettivo. Per questo, è importante l’indipendenza del giudizio e per questo il conflitto di interessi qualifica come non credibili: non potremo mai usare l’opinione, qualunque essa sia, per squalificare chi l’ha espressa, ma potremo valutare la presenza o meno di un conflitto di interessi che la priverà, eventualmente, di credibilità.
(tipicamente, chi gode di una posizione dominante per via dell'efficacia del conflitto di interessi che la regge, amerà squalificare il giudizio altrui sulla base del giudizio stesso, un atteggiamento censorio atto a proteggere il suo privilegio dalla concorrenza per accaparrarselo)
Come e perché possono nascere rapporti economici fra le aziende produttrici e chi critica i prodotti (tipicamente testate, influencer e testate che hanno convertito le proprie firme in influencer visto il successo di quel modello)? Come mai succede una cosa del genere?
I consumatori che non si limitano alle pubblicità usano le recensioni per decidere quale prodotto comprare. Un rapporto economico con testate e influencer conferisce alle aziende un controllo maggiore sul mercato sottomettendo una variabile non più indipendente e facendo rientrare le recensioni di un prodotto nel marketing del prodotto stesso al fianco delle altre forme di promozione (d’altra parte pubblicità e recensioni saranno visibili le une accanto alle altre e una contraddizione forte potrebbe ridicolizzare la campagna danneggiando l’immagine del prodotto).
Questa accortezza da parte delle aziende basa la propria efficacia sulla percezione, da parte del pubblico, che le recensioni in conflitto di interessi siano ancora credibili. Addirittura, che lo siano più delle altre.
Come riescono le aziende a preservare la credibilità di testate e influencer con cui hanno rapporti economici e addirittura a conferire loro una credibilità maggiore rispetto a chi fa critica indipendente?
Le aziende produttrici hanno la facoltà di dispensare privilegi a testate e influencer mediante esclusive e anteprime rispetto ai prodotti, dando loro un vantaggio competitivo incolmabile da parte di chi di quei privilegi non goda. L’accesso a un prodotto prima che questo sia distribuito sul mercato consente a chi ce l’ha di aumentare enormemente la portata del proprio lavoro con i vantaggi economici che ne conseguono, vantaggi non ottenibili diversamente e che solo le aziende possono dispensare. Di fatto, mediante i privilegi di accesso che solo loro possono dare, le aziende produttrici intervengono sul posizionamento di testate e influencer rispetto ai loro concorrenti e colleghi, gerarchizzando la critica.
Qui va fatta una annotazione importante: i privilegi accordati dalle aziende non fanno parte della competenza necessaria per emettere un giudizio critico e non ne sono un attestato (quei privilegi attestano una portata, intesa come reach dei contenuti, e una garanzia di non problematicità degli stessi) e chi lo sostiene intende squalificare l’indipendenza come incompetente per ovvi motivi. L’estrema difesa del conflitto di interessi consiste appunto nel sostenere che sia l’unica posizione dalla quale è possibile esprimere un giudizio e che le altre posizioni non possano farlo. Con questo ragionamento si giustifica il cortocircuito per cui le aziende, elargendo privilegi, elargirebbero competenza. Se così fosse, la critica di un prodotto sarebbe possibile solo se autorizzata da chi lo produce, di fatto rendendo la critica indipendente una non-critica e quella in conflitto di interessi l’unica possibile: la libertà, oltre a costare caro, per giunta squalificherebbe. Uno scenario ideale per chi quella libertà soffre (tipicamente, perché ha venduto la propria).
Al contrario, l’indipendenza è un tratto ineludibile della competenza, perché partecipa del rispetto per il pubblico e per la passione cui ci si è votati.
(Qui bisogna fare attenzione all’illusione che vi siano testate o influencer così importanti o autorevoli da “costringere” le aziende ad accordargli privilegi a loro rischio e pericolo. C’è sempre vasta offerta di chi vuole vendersi e quei privilegi, come abbiamo detto, spostano in fretta le gerarchie: le aziende produttrici tengono il coltello ben saldo dalla parte del manico).
È anche importante notare come non tutti i produttori elargiscano o possano elargire privilegi a testate e influencer (di solito saranno le aziende più importanti a farlo in modo massiccio ed economicamente decisivo) e quindi per chi fa critica in conflitto di interessi (cioè non fa critica) sarà sempre possibile per così dire “rifarsi una verginità” quando alle prese con prodotti di aziende con cui non intrattiene rapporti. Tuttavia, le cose non sono così semplici. In generale, non è serio essere indipendenti solo verso alcuni prodotti, siccome il confronto fra prodotti concorrenti o comunque afferenti allo stesso mercato è parte integrante della critica e della formazione del giudizio dei consumatori. Non si può essere indipendenti a giorni alterni o a seconda dei prodotti analizzati siccome la descrizione complessiva del mercato che si darà non sarà credibile nel suo insieme.
In particolare, è il lancio di un prodotto il momento più importante per la sua sorte commerciale e un’azienda ha modo di esercitare un controllo sul lancio mediante la costruzione dell’aspettativa, dell’anticipazione da parte del pubblico: il cosiddetto “hype”. Qui, la distribuzione dei privilegi che abbiamo detto lavora in stretta sinergia con le altre strategie di comunicazione e marketing, convogliando l’eccitazione irriflessa della gran parte dei consumatori (coloro il cui giudizio è instradato dal desiderio indotto) verso testate e influencer che sono state dotate degli strumenti per dare a quell’eccitazione copertura e sfogo. In questo modo, il pubblico sarà fidelizzato proprio verso la critica non credibile per via del conflitto di interessi, vedendo in essa non più la depositaria di una contraddizione basilare ma l’unica fonte di ciò che chiede ossia la conferma e il rinforzo del desiderio indotto dalle aziende produttrici. I fan sciameranno verso i depositari dell’accesso esclusivo all’oggetto che amano, associando quelli a questo.
Siamo in presenza di un circolo virtuoso, per i produttori, che ha nella vendita la sua finalità: testate e influencer dominanti sono le uniche ad avere accesso ai prodotti prima della loro distribuzione e restano dominanti finché sono le uniche ad avere accesso ai prodotti prima della loro distribuzione. Da un punto di vista economico, ottenere dalle aziende questo vantaggio ha un grande valore e perderlo è un declassamento rimediabile solo ottenendolo di nuovo. In questo senso, l’interesse economico di testate e influencer è legato alle preferenze accordate dalle aziende produttrici (che naturalmente possono dispensare anche inserzioni, accordi di sponsorizzazione, accordi di copertura ad hoc, prodotti gratuiti e così via) e sarà di capitale importanza sapersi meritare queste preferenze.
Dal punto di vista delle aziende, la critica con cui si hanno rapporti economici è marketing esternalizzato e i critici prescelti, di fatto, testimonial.
Dal punto di vista di testate e influencer la situazione si presenta come problematica in quanto contraddittoria su due livelli: quello economico e quello critico. Da un lato, la buona salute del bilancio economico è condizione necessaria alla prosecuzione dell’attività, dall’altro la subordinazione alle preferenze accordate dalle aziende priva il lavoro svolto di credibilità da un punto di vista critico.
Chiunque decida di occuparsi criticamente di una qualsivoglia categoria di prodotti deve decidere se correre o meno il rischio di farlo da una posizione indipendente la quale godrà, sì, di una credibilità impossibile altrimenti, ma (e paradossalmente) del favore di un pubblico assai ridotto e per questo dovrà scontrarsi con grandi difficoltà per quanto riguarda la sostenibilità del progetto.
Se un progetto che rinuncia alla credibilità si finanzia barattando l’indipendenza con i privilegi accordati dalle aziende produttrici, un progetto che si voglia credibile (e quindi indipendente) dovrà ricorrere ad altre forme di finanziamento (fra queste vanno annoverate certamente le sponsorizzazioni di prodotti non afferenti all’area di cui ci si occupa: se un influencer che si occupa di libri sponsorizza una merendina non cade nel conflitto di interessi a meno che l’azienda di merendine non sia presente anche nel mercato dei libri. Tuttavia, le sponsorizzazioni tendono ad avere a che fare con il settore di cui ci si occupa e quando non è così raramente sono consistenti - salvo casi di testate o influencer così grandi da giustificare un posizionamento basato esclusivamente sui dati demografici della loro utenza).
Soltanto un pubblico che riconosca un valore all’indipendenza del pensiero critico può garantirne la sopravvivenza e questo oggi è possibile non solo attraverso le interazioni che aumentano la portata dei contenuti (click, visualizzazioni, like, commenti, iscrizioni, innesco di pubblicità e così via) ma anche attraverso strumenti di finanziamento quali Patreon, abbonamenti, fundraising e simili. La stessa rete che premia la quantità, la frequenza di contenuti insignificanti al solo scopo di rimanere visibili (si pensi ai tantissimi articoli spazzatura che le testate producono a getto continuo e che consentono loro di avere sempre qualcosa di nuovo da dare in pasto a chi ancora le premia) offre anche gli strumenti per rendere possibile la qualità e il pensiero critico indipendente... almeno in teoria.
Perché ho citato l’Italia nel titolo del video? Il discorso fatto finora non ha nazionalità e non c’è nessun bisogno di stringere il campo al nostro paese. Eppure, l’esempio nostrano è interessante per banali ragioni numeriche che riguardano la distribuzione del pubblico. Se possiamo immaginare che un pubblico dotato e in cerca di pensiero critico sia sempre una minoranza rispetto alla maggioranza dei consumatori più superficiali (e che, banalmente, le stesse persone cerchino più spesso lo svago che la problematizzazione) allora dobbiamo domandarci quali dimensioni debba avere un mercato per offrire una nicchia abbastanza grande a chi voglia rimanere indipendente. Basta YouTube per verificare come, sul mercato internazionale (in lingua inglese) siano molti i creatori di contenuti indipendenti che possono contare su di un grande seguito che premia un’impostazione incentrata sulla qualità per così dire senza compromessi. Si tratta naturalmente di numeri irrisori rispetto a progetti commerciali di stampo opposto, ma comunque più che sufficienti per dare al pensiero critico il suo spazio sicuro e al pubblico una vasta offerta di voci indipendenti.
Anche tenendo ferma, in uno slancio di ottimismo, la proporzione fra contenuti commerciali e non, il mercato italiano (ma online sarebbe meglio dire: in lingua italiana) risulta così piccolo da non consentire alla critica indipendente di contare su di una nicchia sostenibile di utenti interessati e questo si nota soprattutto facendo caso al culto della propria personalità che hanno imbastito anche i più in gamba dei nostri content creator per poter sopravvivere (o, darwinianamente, sono sopravvissuti quelli che ne hanno imbastito uno) e infatti dispongono in larga parte di una utenza che li idolatra acriticamente, come verificabile da certe sezioni commenti, e che gioisce per ogni passo che compiono verso il personaggio e allontanandosi dal contenuto (come si suol dire, “essere qualcuno” vs. “fare qualcosa”). Di fatto, un’utenza che li segue per il motivo “sbagliato” perché il motivo “giusto” non basterebbe.
Questa selezione che potremmo definire anti-qualitativa è dovuta al fatto che in un mercato come il nostro non ci sono i numeri (o ci sono appena, e per pochissimi - rispetto alla grande pluralità in lingua inglese) per fare diversamente. Le persona genuinamente interessate al pensiero critico indipendente (ma come abbiamo visto un pensiero critico autentico, che si voglia credibile, può solo essere indipendente) non sono abbastanza a tutto danno della discussione pubblica nostrana generalmente più conformista e meno plurale di quella internazionale in lingua inglese (che può contare su contributi da tutto il mondo, ben oltre i confini di quello anglofono).
Che si fa allora? Si lotta per sopravvivere cercando di sensibilizzare il pubblico e lottando per il pensiero critico e per la sua diffusione. Generalmente, considererei questo un pio proposito, ma la situazione nostrana è a tal punto asservita al non-pensiero innocuo che forse esiste lo spazio per un rimbalzo in senso opposto. In ogni caso, chi proprio non digerisce l’idea di sottomettere il proprio giudizio a uno scambio commerciale, chi si trova impossibilitato ad anteporre convenienza a indipendenza, non ha scelta - anche a fronte del fatto che comporti l’assistere al successo dell’atteggiamento opposto. Quel successo non deve farci desiderare di emularlo, siccome corrisponde al convertirsi da autori (il critico è un autore) a markettari. Cosa c’è di desiderabile in questo?
So many times it happens too fast
You change your passion for glory
Don't lose your grip on the dreams of the past
You must fight just to keep them alive
(questo articolo è il testo del video qui sopra, che ho pubblicato su WesaChannel il 21 dicembre 2020)
Postille 2022:
Questo testo non parla di videogiochi ma è stato percepito come un testo sul mondo dei videogiochi: nel suo piccolo, ha avuto un’eco nel dibattito videoludico nostrano. Credo che basti questa considerazione a descrivere la situazione della critica videoludica in Italia.
***
La pubblicità sogna di non essere percepita come tale e il suo travestimento in opinione (il testimonial spacciato come critico) è prezioso siccome favorisce sua maestà la vendita. La fidelizzazione dei fan consente di inoculare pubblicità mediante una comunicazione percepita come sincera: è l’idolo che parla. Chi crede gioisce delle conferme al proprio credo e chi gliele somministra sarà premiato commercialmente e difeso gratis a tempo perso per pura gratitudine.
***
Idolatri di venditori per passione indotta, i fan si onorano di essere i bersagli della pianificazione commerciale altrui, lo considerano un privilegio e gioiscono sinceramente del successo di quella strategia che contribuiscono a realizzare (è il loro ruolo, e lo interpretano con fervore e sincero appagamento). Il fan non riflette sui propri gusti ma si sottomette volontariamente a chi li legittima.
***
L’indipendenza non è commerciale, è critica. Non riduce l’attrito, lo acuisce. Punge dove ci si attende una carezza, mette a disagio, sposta la sedia quando ci si sta per accomodare. La vendita è guardata con sospetto siccome l’unico consumo libero è un consumo critico: difficilmente sarà a buon mercato. L’indipendenza antepone la libertà alla convenienza perché, in fin dei conti, sa che conviene essere liberi: nel caso corrisponda a una rinuncia alla propria indipendenza (in questo caso, indipendenza di giudizio), un arricchimento contabile non compensa quel che sottrae. Liberi, si vive meglio.
***
La difesa di posizioni indifendibili segnala una impossibilità. Che sia oggettiva o soggettiva, dipende dai casi. Di certo, chi non è libero è un interlocutore menomato perché il suo spettro del dicibile ha limiti contrattuali pregressi: la sua facoltà di cambiare opinione pubblicamente è irregimentata e la sua onestà intellettuale soggetta a clausole. Il costo della libertà è anche il suo premio.
***
Anteporre l’indipendenza alla vendita non significa demonizzare il mercato, ma riservarsi un approccio critico agli scambi.


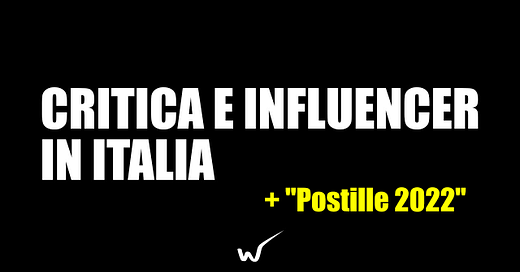


Tutto certamente sottoscrivibile e condivisibile, come quando è stato pubblicato l'eponimo video. Se penso però al paragone enologico mi chiedo se una critica professionale e seria sarà mai possibile: chi se non ha interesse a venderti il proprio prodotto o a screditare il concorrente è sul mercato a parlarne con preyesa di cognizione di causa? Si badi bene, non l'amico esperto, non l'opinione più o meno affidabile da forum ma chi si intesta, da sé o per interposizione, questo ruolo. Realisticamente il mecenatismo non è praticabile, benché auspicabile, perché a lungo termine non si sostiene, ci vorrebbe un collettivo nutrito e coinvolto, sicuramente mosso dalla passione ma anche competente nel tempo. Una "Tripadvisor" della critica (per ogni settore, se non si vuole confinare il tema ad uno in particolare), purtroppo sappiamo cosa diventano queste piattaforme. A mio avviso, bisogna far pace con l'esistenza dei gruppi di interesse e i loro conflitti e divenire dei fruitori più consapevoli. Ingenuo, forse, certamente auspicabile ma necessario quando si esce a far la spesa e per il proprio benessere ☺.
Approfondimento sulla critica letteraria.
Giuro che l'autore non è lo stesso di questo articolo, anche se alcuni paragrafi... fanno rima.
https://www.iltascabile.com/letterature/sparlarne-tra-amici/